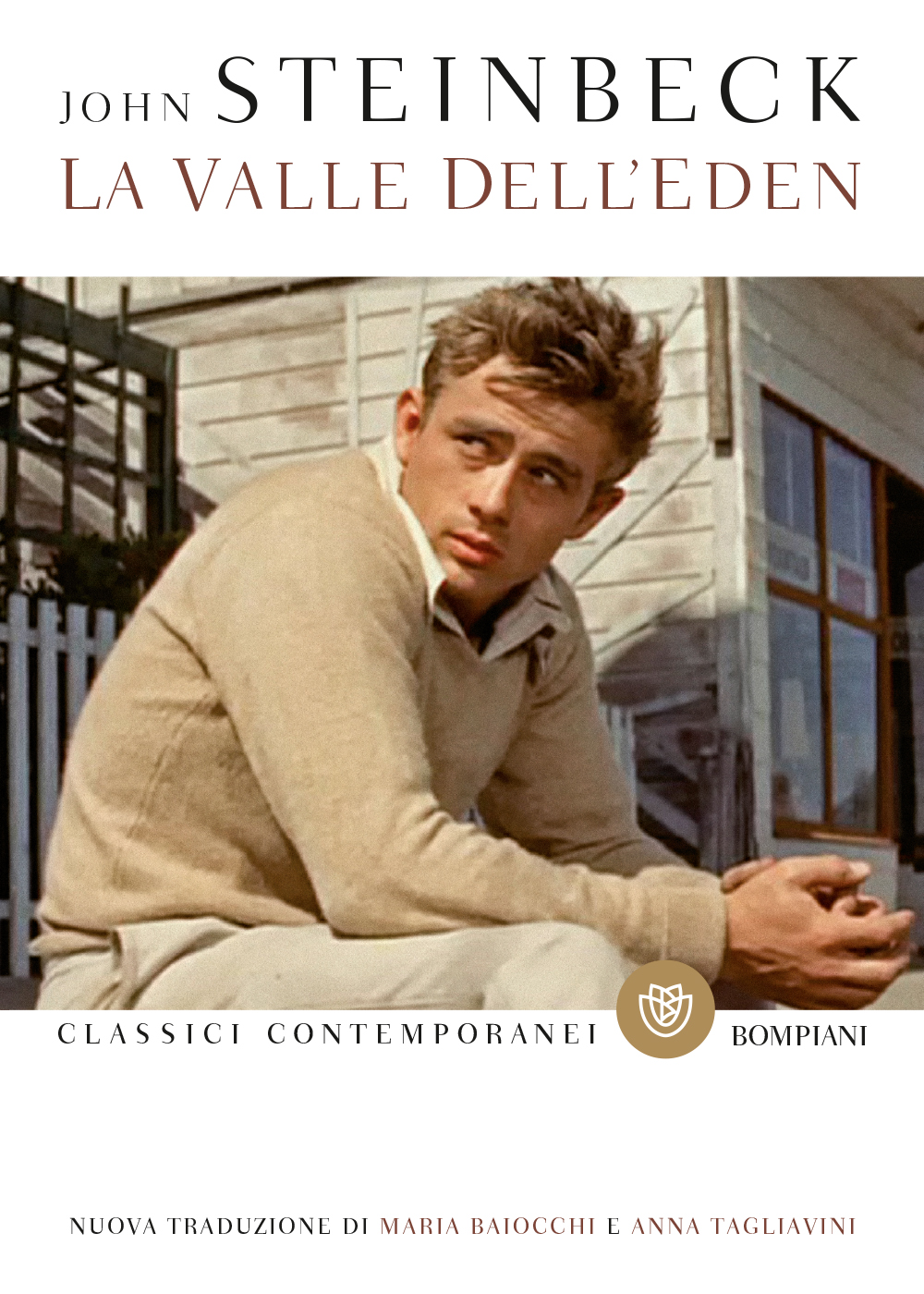Da qui non può che essere tutto in discesa.
Questo blog è sempre stato il mio piccolo angolino libero, in cui fare ciò che più mi aggrada. Non ci sono regole prestabilite, se ci sono le ho decise io e se non riesco più ad adattarmici le cambio. Da qualche mese ormai sentivo la tentazione di ricominciare a scrivere, nonostante possa non sembrare il momento più adatto. Di tempo per leggere ne avrò poco, per scrivere ancora meno, e avrò così tanti di quei pensieri che potrebbe essere complicato tirare fuori la matassa dalla mente e svolgerla a beneficio di una persona esterna – o a mio beneficio, se è per questo.
Le novità son presto dette: Il Fidanzato ha ricevuto una promozione a Il Marito e Noi Due stiamo per diventare Noi tre. A breve. Brevissimo. Da un momento all’altro, tanto che mi sento come una bomba a orologeria. Nonostante questo, o forse – chissà – proprio per questo, il desiderio di scrivere e di leggere e di parlare di libri si è amplificato fino a raggiungere proporzioni elefantiache ed eccomi qui. Magari, in un momento in cui tutto sta per cambiare, ho bisogno di fare qualcosa per me, di ricordarmi che è mio dovere ritagliarmi un pezzettino che è solo mio.
Da qui non può che essere tutto in salita, ma per fortuna mio marito mi ha fatto conoscere le meraviglie della montagna – a me, che sono un’amante del mare – e le salite non fanno più così orrore.
Quindi parliamo di libri.
Non avevo un’idea precisa di ciò che avrei detto quando ho iniziato a scrivere questo post, ma le parole si srotolano da sole sulla pagina e ora è come guardare una vallata dall’alto: non se ne capisce la portata quando si è in fondo, ma sulla cima se ne gode il panorama e si notano le forme, i sentieri già percorsi e la strada per ridiscendere, ed è subito chiaro che cosa si debba fare.
Negli ultimi anni ho ricominciato a rileggere libri già letti, cosa che prima evitavo con cura. Ho scoperto che non mi dispiace e vorrei dedicarvi un post a parte. La rilettura è un argomento che va trattato con i dovuti modi, si merita un suo post.
Un’altra abitudine che ho preso è quella di leggere saggi. Prima non leggevo saggi. Non sapevo su cosa buttarmi, temevo che fossero noiosi, o complessi, o forse non avevo ricevuto la spinta necessaria a uscire dalla mia comfort zone, ovvero i romanzi. Be’ non so come è iniziata, non ricordo, fatto sta che adesso metà della mia wishlist è composta da saggi e mi sembra di non averne mai abbastanza.
Come al solito comunque sono molto severa con ogni libro che ha la sventura di capitare sotto il mio scrutinio (è una fortuna che io non faccia l’insegnante o sarei quella stretta di voti che tutti gli studenti odiano) e, dando un’occhiata alle lettura degli ultimi anni, quelle che mi sono rimaste impresse a distanza di anni sono davvero poche.
Ho lasciato con Steinbeck e riprendo con Steinbeck:
La valle dell’Eden. Autore per me ormai collaudato, non ha deluso neanche questa volta. A distanza di anni del romanzo ricordo le atmosfere, più che la trama: un’America soleggiata, calda, una famiglia che basa la sua esistenza sui valori di una volta, su delle sicurezze stoiche che, di lì a qualche anno, verranno smembrate, soppiantate dalla rivoluzione culturale e sessuale degli anni ‘60. Mi ricordo un’America che non scende a patti, che vede le cose bianche o nere, e sono in pochi coloro che accettano un mondo fatto di compromessi, di sfumature e di verità relative. Il protagonista è uno di loro, bollato come ragazzo ribelle dall’animo oscuro, si scontra con il padre e il fratello, entrambi troppo attaccati al sogno americano, alla patina che lo riveste, per accettare che il mondo non è così semplice. Eppure, legati indissolubilmente, i due fratelli incarnano uno la cecità di fronte al cambiamento, l’altro la curiosità per lo stesso.
Una lettura che ricordo sempre con piacere è Nel guscio di Ian McEwan. Storia di un Amleto senza nome che assiste impotente al complotto della madre e dello zio per uccidere suo padre. Impotente perché assiste a tutto ciò dall’interno del proprio guscio: il grembo della madre. Il suo unico potere? Venire al mondo. Di questo libro ho anche visto la trasposizione teatrale, un lungo monologo recitato benissimo da Marco Bonadei. Ora, non mi intendo di teatro, ma essere soli sul palco, parlare per due ore e non annoiare è certamente una sfida. Consigliatissimo il libro e, a chi piace, anche lo spettacolo.
Un romanzo cui sono legata più da un punto di vista sentimentale, probabilmente, è They both die at the end, di Adam Silevera. Forse perché l’ho comprato a New York, durante il viaggio del matrimonio/luna di miele. Visitare un paio di librerie storiche era nelle tappe del viaggio e, alla Strand, ho comprato questo YA di cui avevo già sentito parlare e che ancora non era arrivato in Italia (ora c’è, con il titolo L’ultima notte della nostra vita, mi pare). Storia godibile e, come si nota dal titolo, dal finale tragico ma che in qualche modo va bene così. Uno di quei finali amari che vorresti fosse diverso ma, allo stesso tempo, sai che quel finale è quello giusto – purtroppo.
Altra autrice che per me è già intoccabile e di cui leggerei anche la lista della spesa è Amélie Nothombe, di cui ho scoperto Sabotaggio d’amore. Uno dei suoi libricini sottili, che rischiano di passare inosservati o incompresi. Personalmente è un’autrice che mi mette in soggezione, forse per la misura immensa del suo ego, o forse per il fatto che può addirittura permetterselo, un ego così smisurato. Una volta ragionai sul fatto che alcuni degli artisti più bravi sono quelli che, di persona, sembrano più antipatici. La Nothombe sembra così. Perché avere la presunzione di scrivere un romanzo su un periodo della propria infanzia durato pochi mesi e che, a posteriori, può essere considerato irrilevante, richiede una fortissima convinzione di essere interessanti. E ci vogliono tanto fegato ed egocentrismo per farlo. E tanto talento anche.
Uno dei primi saggi su cui mi sono lanciata è stato un classico di un tema a me caro, il femminismo. Ho pensato di iniziare dalle basi e leggere Il secondo sesso, di Simone de Beauvoir. Una pietra miliare, posso dire a posteriori, che tuttavia va collocata nel suo tempo. La Beauvoir è decisamente all’avanguardia sulla maggior parte dei temi trattati, ma ancora figlia sul tempo per altri. Nonostante questo ritengo che sia una lettura base per chiunque voglia affacciarsi su questo tema, o sarebbe come voler correre ancor prima di aver imparato a camminare.

Per rimanere in tema saggi, uno di tutt’altra natura ma considerato un classico di quella tematica è Armi, acciaio e malattie, di Jared Diamond. L’autore, geografo e antropologo, illustra come l’evoluzione delle popolazioni sia intrinsecamente legata al luogo in cui si sono sviluppate. Le popolazioni dell’Eurasia hanno avuto uno sviluppo più veloce rispetto a quelle isolate dell’Oceania, o a quelle dei climi meno favorevoli come l’Africa e le Americhe. Diamond spiega cosa ha favorito questo sviluppo e cosa lo ha ostacolato, con un linguaggio estremamente chiaro. L’unica critica che si può muovere al libro è che, verso la fine, diventa un poco ripetitivo: le cause che secondo l’autore vanno a inficiare sullo sviluppo tecnologico sono sempre le stesse, e sebbene ci siano differenze fra un continente e l’altro, ovviamente, il succo della questione rimane lo stesso e la lettura si fa monotona negli ultimi capitoli.
Avevo accennato tempo fa al fatto che la cultura giapponese mi affascina. È difficile trovare romanzi di autori giapponesi che non siano i soliti due o tre che vengono citati da vent’anni, così mi sono informata e ho deciso di iniziare dai classici moderni. Ho scovato Yukio Mishima, un personaggio particolare la cui vita è stata una fitta rete di contraddizioni, ma la cui penna mi ha conquistata. Ho letto Confessioni di una maschera, romanzo d’esordio in cui sceglie di rivelare le proprie passioni omosessuali e, in alcuni casi, particolarmente estreme (un interesse anche troppo entusiastico nei confronti del sangue, dei martiri e delle ferite), insieme alle proprie insicurezze adolescenziali, alle paure e alla brama contraddittoria di vivere per sempre e allo stesso tempo di morire gloriosamente. Si intravede la figura di un giovane che, nonostante le stranezze, suscita tenerezza e in alcuni casi compassione. Non so se abbia scritto altri libri autobiografici, in ogni caso sono curiosa di conoscere questo autore un po’ folle e un po’ timido in queste pagine si rivela con sincerità e coraggio.
Per tornare ai saggi ho letto qualcosa che non mi sarei mai aspettata di leggere, anche solo un paio di anni fa. L’unica regola è che non ci sono regole, intervista dell’autrice Erin Meyer a Reed Hastings, fondatore di Netflix. Ho fatto l’abbonamento a Netflix, cedendo alle pressioni, poco prima dell’inizio della pandemia – quindi una decisione che si è rivelata fortuita nei lunghi mesi di reclusione – e quando ho visto questo titolo ho pensato che sarebbe stato interessante leggere la storia dell’azienda. Peccato che non si tratti della storia dell’azienda, ma della sua politica. Se lo avessi capito prima probabilmente non lo avrei letto, ma per fortuna non l’ho capito e ho scoperto una cosa nuova su di me: mi interessa questo argomento. Hastings racconta delle strategie che utilizza con i suoi collaboratori per fare in modo di avere un’azienda di successo. Alcune possono sembrare bislacche a noi italiani visto che la cultura del lavoro negli USA è molto diversa, ma i principi su cui si basa sono universali e molti sono applicabili anche qui. Sono abbastanza convinta che da qualche parte il signor Hastings voglia mettere in buona luce il suo prodotto, e che forse ci sono alcune cose non dette, ma non si può ignorare il fatto che egli ha, effettivamente, fondato un’azienda di videonoleggio e, mentre Blockbuster affondava, Netflix faceva il botto. Il libro offre anche uno spaccato su com’è lavorare negli Stati Uniti, il che fa venire un po’ voglia di tenersi alla larga da quel posto, ma rimane comunque una lettura interessante.
Per avvicinarmi alle lettura più recenti, infine, ecco Cecità di José Saramago. L’autore non ha bisogno di presentazioni, e forse la storia è arrivata nel momento giusto: né troppo addentro alla pandemia da non permettere di concentrarsi sulla narrazione, né troppo al di fuori da non ricordare la situazione come fosse ieri. Durante i mesi di lockdown vedevo sul web tanta gente, una volta passata la fase di shock iniziale, cominciare a consigliare alcuni libri da leggere a tema ‘malattia’, alcuni dei più gettonati erano La peste di Camus e L’ombra dello scorpione di King. Mi chiedo ora perché nessuno abbia parlato di Cecità. La trama è semplicissima, nel mondo si diffonde una malattia che rende ciechi dall’oggi al domani e la società collassa nel giro di un paio di settimane. È impressionante il fatto che Saramago abbia descritto alcune delle situazioni che si vengono a creare senza aver vissuto in prima persona una pandemia (almeno, non credo che l’abbia vissuta, ma avrà sicuramente sentito storie sull’influenza spagnola e magari, chissà, si è rifatto a quelle). Prima l’incredulità, la sensazione che non possa capitare a noi, poi il panico quando inizia a diventare virale. La costruzione di centri di raccolta per i malati, la paura dei sani nei confronti degli infetti, che si trasforma in vera e propria violenza pur di scampare al contagio. Le misure insufficienti che vengono prese dal governo e la gestione inefficace di fronte a una situazione così grave e sconosciuta. Infine – e qui per fortuna sfociamo nella pura ipotesi perché non siamo arrivati a tanto – la violenza senza quartiere che si genera in una situazione disperata, ciò che si è disposti a fare per sopravvivere, quanto si può scendere a patti con la propria umanità per conservare la propria vita. Ancora non mi sento di consigliare questo romanzo a tutti, proprio per la vicinanza con un fenomeno che ha così radicalmente cambiato le nostre abitudini e concezioni, e che per il resto della vita segnerà uno spartiacque. Non leggetelo, se ancora non avete preso le distanze.

Appena qualche mese fa, infine, ho letto
La vegetariana, di Han Kang. Anche questo libro è stato scelto per curiosità nei confronti della letteratura estera. Leggo molti autori americani e inglesi, che si prendono larga fetta del mercato, e ovviamente italiani. Gli europei poi arrivano più facilmente in Italia, per una questione puramente geografica immagino, ma ci sono dei luoghi che rimangono nel lato oscuro della luna. Di libri di autori sudamericani, ad esempio, si parla pochissimo, di romanzi di autori di origine africana ancora meno, e gli autori asiatici si devono andare a cercare per trovare qualcosa. Fortuna che oggi la ricerca è più semplice, così ho deciso di leggere La vegetariana, ricordando il successo che aveva avuto e pensando che, dato che non ho mai letto nulla di un autore coreano, potevo iniziare da lì. Ho avuto un graditissima sorpresa, tanto che ho già in wishlist il prossimo libro della Kang nella sua traduzione inglese (perché non è edito in Italia). La cosa che più mi ha rapita è lo stile secco dell’autrice, in linea con la storia che racconta. Il modo spoglio e pacato di raccontare la storia di una donna che sceglie di spogliarsi di tutto ciò che è inutile, e mentre lo fa si rende conto che ogni cosa, in fondo, è inutile. Abbandonate le convenzioni, a iniziare dal modo di mangiare, la protagonista decide di lasciarsi andare solo a ciò che veramente desidera, senza pensare alle conseguenze o ai giudizi altrui. Ogni piccola libertà che si prende è come togliere uno strato alla realtà e scoprire che c’è un altro strato che può levare, un altra usanza irragionevole di cui, si rende conto, può fare a meno. E così avanti fino a raggiungere il nocciolo, fino a spogliarsi completamente di ciò che ritiene superfluo.
Dopo questa che era decisamente una scalata di titoli, vi lascio in pace ad ammirare la vallata, sperando che magari abbiate trovato qualche titolo di vostro gradimento. Non c’è molto altro da dire, se non che spero di tornare presto a scrivere con regolarità, anche se la vita ci mette sempre in mezzo lo zampino. E questa volta non posso che esserne felice.