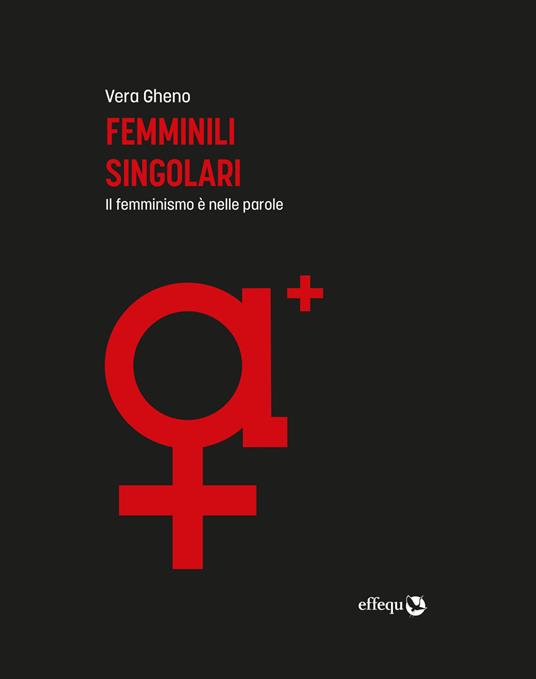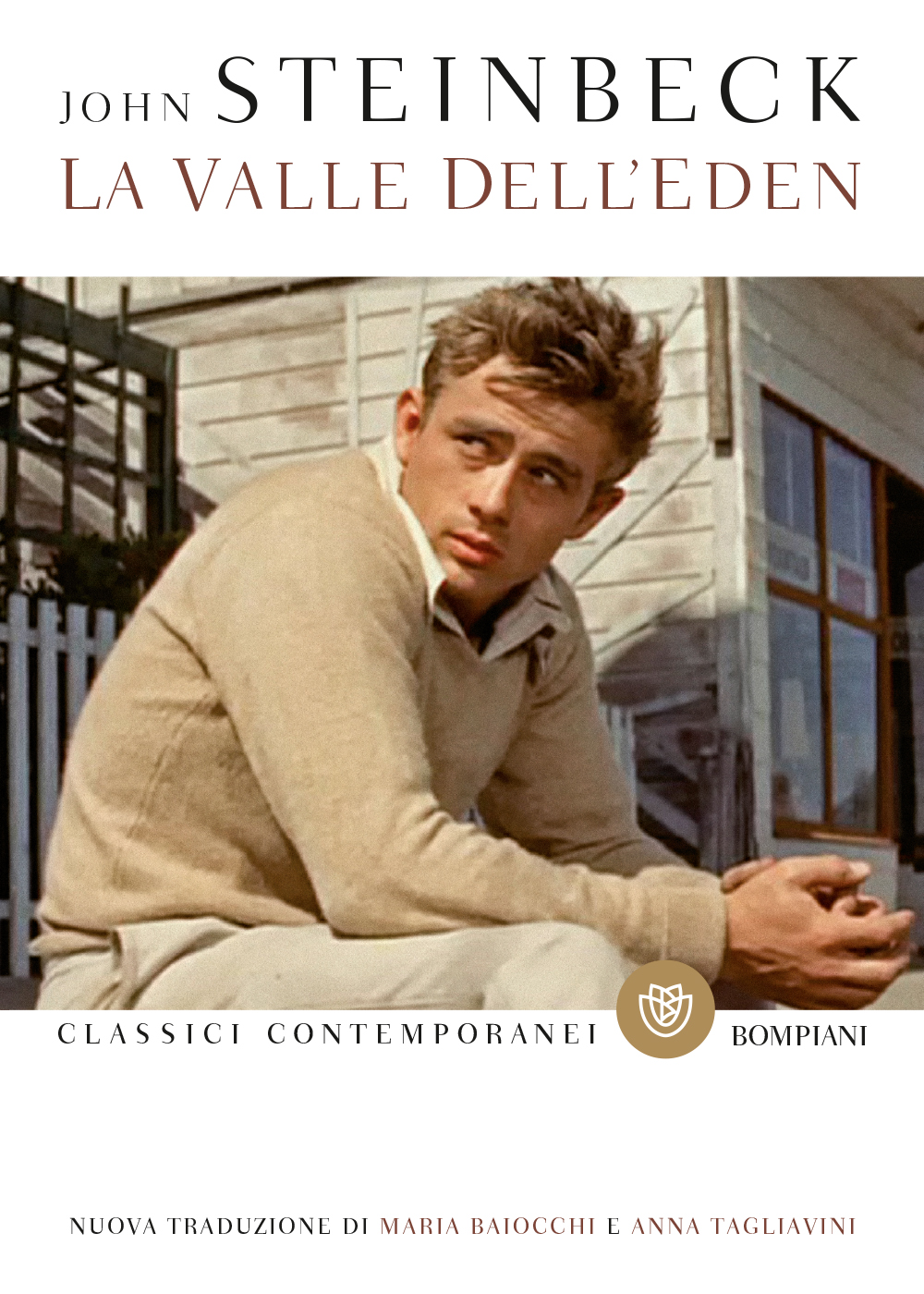Qualche anno fa era molto il voga
il discorso sulla lingua italiana, prima per via del femminile
professionale e poi per i tentativi di introdurre la neutralità di
genere in una lingua che, neutra,
non lo è. Tutti ne parlano e dappertutto, dai professionisti ai
politici, dai giornali ai social. Non è più un argomento caldissimo
ma io ho di recente letto il saggio di Vera Gheno al riguardo,
“Singolari femminili”, che
si occupa proprio dell’introduzione del femminile professionale nel
parlato di tutti i giorni.
Ho
letto questo saggio in parte perché immaginavo quale fosse la sua
posizione, e magari volevo solo un po’ di sostegno da parte degli
esperti. Avevo già sentito parlare dell’autrice, di professione
sociolinguista, in un podcast se non ricordo male, e da allora è
sempre rimasto un nome che ricordo. Quindi in parole povere, sì, io
dico sindaca, assessora, architetta,
e chi non desidera essere chiamata in quel modo può semplicemente
dirmelo e mi correggerò.
Non ho intenzione di sviscerare
tutte le motivazioni che mi portano ad essere d’accordo con questa
evoluzione della lingua, anche perché sono sempre le stesse che di
certo avrete già sentito se avete chiacchierato dell’argomento
anche solo una volta. Vorrei parlare di qualcosa di diverso su cui il
saggio di Vera Gheno mi ha fatta riflettere.
Coloro
che si ergono a difesa dell’italiano, affermando che termini come
portiera per indicare
un portiere donna, non esistono, sono davvero convinti di fare il
bene della nostra lingua. Io mi definisco femminista ed è uno dei
motivi per cui sono d’accordo con questo
cambiamento e non vedo né
come possa essere contrastato,
né perché dovremmo farlo (al contrario, credo
dovremmo incoraggiarlo).
Riconosco comunque che
non tutti coloro che si battono per mantenere l’italiano com’è
adesso sono
maschilisti. Penso che ci sia una fetta di persone genuinamente
devota
alla lingua, che
la vedono come qualcosa di sacro e immutabile, e per loro il modo in
cui ci esprimiamo non ha nessuna relazione con il nostro credo
politico o sociale.
È questa fetta che, secondo me,
non ci ha pensato più di tanto alla propria posizione.
Oltre
alle questioni sociali, sono d’accordo con il cambiamento proprio
per una questione di lingua, perché mi piace la lingua. Le lingue,
in generale, mi divertono. Mi piace scoprire l’etimologia di certe
parole che vengono dal latino o dal greco. A volte mi capita di
confrontare alcuni dialetti con lo spagnolo e ci sono tante parole
che sono proprio uguali, come chicle,
che significa gomma da masticare sia in spagnolo (quello sudamericano
del Perù, che è quello che
conosco per via dei miei genitori)
che, a quanto pare, in provincia di Torino – così mi disse una
ragazza torinese una volta. Oppure è divertente scoprire che alcune
parole italiane di uso comune, come ad esempio bistecca, vengono da
una modificazione dell’inglese beef steak,
ossia ciò che chiedevano i soldati inglesi stanziati in Italia nelle
osterie quando volevano vedersi servire una fiorentina.
La
lingua è in perpetuo cambiamento, basta pensare alle vecchie
edizioni dei romanzi. Vi sarà capitato di avere per le mani un libro
stampato negli anni ‘50, magari un classico straniero,
e di confrontare il linguaggio utilizzato con quello dell’edizione
aggiornata. Molte parole risultano desuete (un po’ come la parola
desueto, se è per
questo), e a volte la costruzione della frase pare macchinosa. Non è
a causa del libro, è per via della traduzione. I traduttori hanno il
compito di far comprendere al meglio ciò che un romanzo vuole
comunicare, e se settant’anni fa era comune utilizzare la parola
‘figliuolo’ per riferirsi ad un giovane, oggi non avrebbe senso
perché suonerebbe anacronistico, e il traduttore preferirebbe magari
sostituirla con ‘ragazzo’, che rende meglio l’idea ad un
lettore contemporaneo. Questi
sono solo esempi, dato che non sono traduttrice, ma era giusto per
rendere l’idea.
La
lingua cambia ad ogni generazione, ad ogni nuova invenzione, ad ogni
contatto sempre più stretto che le nazioni hanno fra loro. Cambia al
bisogno perché è viva, come noi. Solo le lingue morte hanno delle
regole grammaticali granitiche, lingue che nessuno usa più. Ha senso
dire che in latino non esisteva la parola pantaloni,
perché non avevano bisogno di nominare qualcosa che non avevano. Ma
quando qualcuno ha poi inventato la calzamaglia hanno avuto bisogno
di introdurre questa nuova parola, perché avevano un indumento che
non era una tunica e avevano bisogno che avesse un nome. Le lingue si
reinventano perché i tempi cambiano, per aiutarci ad andare avanti.
In realtà, magari senza rendercene conto, siamo noi a reinventarle
perché ne abbiamo bisogno. Non dobbiamo cercare di fermare lo
sviluppo linguistico, sarebbe come cercare di fermare la crescita di
una persona. Non si può e soprattutto non si deve.
Coloro
che si dicono amanti della lingua italiana, e che quindi non vogliono
usare il femminile di sindaco,
ci pensino un secondo. Che cosa succederebbe se ci fermassimo qui? Se
decidessimo che da ora in poi ogni nuova parola verrà bandita dal
vocabolario? Come chiameremmo le nuove scoperte? O, dopo una
rivoluzione e la formazione di un nuovo paese, come ci potremo
riferire a quel paese e ai suoi abitanti? Se in un futuro ci fosse un
contatto alieno, come dovremmo rivolgerci a loro, senza inventare
nuove parole?
Le parole sono vive perché la
nostra cultura è viva. Quando le regole grammaticali saranno
scolpite sulla carta sarà perché ci siamo estinti e i popoli del
futuro studieranno l’italiano come noi studiamo il sanscrito, senza
nemmeno esser certi di averlo capito appieno. Parlare italiano sarà
un mero esercizio senz’anima, senza poter comprendere e apprezzare
appieno la sua forma e la sua bellezza. Ecco perché dobbiamo
incentivare il cambiamento, andare avanti. In realtà è molto facile
andare avanti: basta seguire il flusso. Basta comunicare.
x